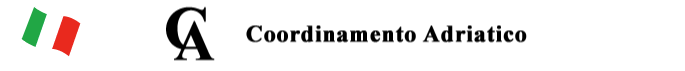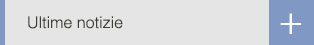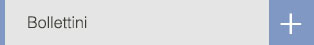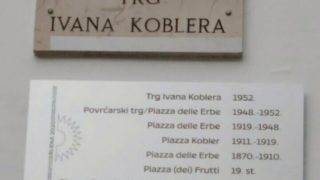Vent’anni fa la fine della Jugoslavia
Scritto da «Il Piccolo», 04/05/11
Vent’anni fa, con la disgregazione della Jugoslavia, cominciava un lungo processo di destabilizzazione della nostra periferia geopolitica, tuttora in corso. La Jugoslavia di Tito era stata di fatto nostra alleata contro la minaccia sovietica. La “soglia di Gorizia” strategicamente non è mai esistita perché la nostra prima linea di difesa contro i sovietici era sulla Drava. Solo che a presidiarla non c’erano truppe Nato ma l’esercito jugoslavo, concepito, istruito e strutturato per resistere a Mosca. Ciò spiega perché il nostro paese non volesse la scomparsa di quel cuscinetto geostrategico. A differenza di Austria, Germania e Santa Sede, l’Italia – come e più di tutti gli altri paesi del mondo, Stati Uniti e Unione Sovietica compresi – si attestò quindi, all’inizio delle crisi jugoslave, sulla trincea della conservazione dell’integrità territoriale del vicino d’Oriente, anche per favorirne la transizione democratica.
Tradizionalmente dedicato ai linguaggi dell’informazione, in occasione della sua sesta edizione Antepremio – l’anteprima del Premio giornalistico Marco Luchetta – si trasforma in una vera e propria agorà geopolitica e punta i riflettori su anniversario di cruciale attualità, i vent’anni dalla guerra nell’ex Yugoslavia, tema portante di una riflessione che vuole estendersi ai tragici venti di guerra degli ultimi mesi, alle rivendicazioni di democrazia e libertà dei popoli nordafricani, alle guerre etnico-religiose che quotidianamente scuotono il mondo e che nel conflitto balcanico hanno certamente trovato un humus deflagrante. “La guerra alle porte di casa – 1991-2011 dal conflitto balcanico alle rivolte del nord Africa” titola la tavola rotonda in programma domani, alle 18, al Ridotto del Teatro Verdi di Trieste; l’incontro, introdotto dal caporedattore Tg Rai regionale Giovanni Marzini, sarà coordinato da Lucio Caracciolo, direttore di «Limes», con la partecipazione dei giornalisti Gigi Riva e Sergio Canciani,e dell’esperto di politica internazionale Dimitrij Rupel, già ministro degli Esteri della Repubblica Slovena.
di LUCIO CARACCIOLO
Vent’anni fa, con la disgregazione della Jugoslavia, cominciava un lungo processo di destabilizzazione della nostra periferia geopolitica, tuttora in corso. La Jugoslavia di Tito era stata di fatto nostra alleata contro la minaccia sovietica. La “soglia di Gorizia” strategicamente non è mai esistita perché la nostra prima linea di difesa contro i sovietici era sulla Drava. Solo che a presidiarla non c’erano truppe Nato ma l’esercito jugoslavo, concepito, istruito e strutturato per resistere a Mosca. Ciò spiega perché il nostro paese non volesse la scomparsa di quel cuscinetto geostrategico. A differenza di Austria, Germania e Santa Sede, l’Italia – come è più di tutti gli altri paesi del mondo, Stati Uniti e Unione Sovietica compresi – si attestò quindi, all’inizio delle crisi jugoslave, sulla trincea della conservazione dell’integrità territoriale del vicino d’Oriente, anche per favorirne la transizione democratica.
Per funzionare, questa strategia avrebbe dovuto vertere su almeno tre premesse. Primo: soldi. Lo Stato jugoslavo aveva bisogno di sostegno finanziario per poter funzionare e tentare di tenere sotto controllo le pulsioni separatiste/nazionaliste che fervevano nel suo corpo. Secondo: forte coesione di tutti gli attori esterni. Ma il fronte dei fautori della “Jugoslavia unita e democratica” mostrò presto alcune crepe, tanto quanto il gruppo dei tre fautori esterni dell’indipendenza slovena e croata era invece compatto. Poi, con la dissoluzione dell’Unione Sovietica (26 dicembre 1991), l’importanza geo-strategica e geopolitica della Jugoslavia precipitava. Non era più l’antemurale dell’Occidente contro possibili invasioni da est, perché quel nemico si era suicidato. Nessuno aveva più un interesse vitale a preservarne l’unità. Terzo: un leader jugoslavo sufficientemente legittimato e autorevole per salvare l’integrità del suo Stato.
Tale personalità non esisteva. Non era certamente Milosevic – abbarbicato nella difesa di una Jugoslavia sempre più piccola, infine ridotta alla precaria unione di Serbia e Montenegro – a poter svolgere una simile funzione. Dodici anni dopo l’ultima guerra jugoslava, combattuta dai kosovari albanesi contro i serbi con il supporto dell’aviazione atlantica, il processo di disintegrazione jugoslava pare ancora lontano dall’essersi compiuto. Specialmente per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, che esiste unicamente sulla carta. Solo Slovenia e Croazia paiono dotate di frontiere terrestri stabili, anche se le loro storiche rivalità sono tutt’altro che sedate. Per noi italiani non è una buona notizia. Tanto più quando la dinamica destabilizzatrice si è estesa al fianco sud, dove siamo impegnati, a nostro modo, nella guerra di Libia. Quando gli storici la studieranno, anche quest’ennesima campagna militare italiana del dopo-guerra fredda sarà interpretata nel contesto del processo iniziato con la fine della Jugoslavia.