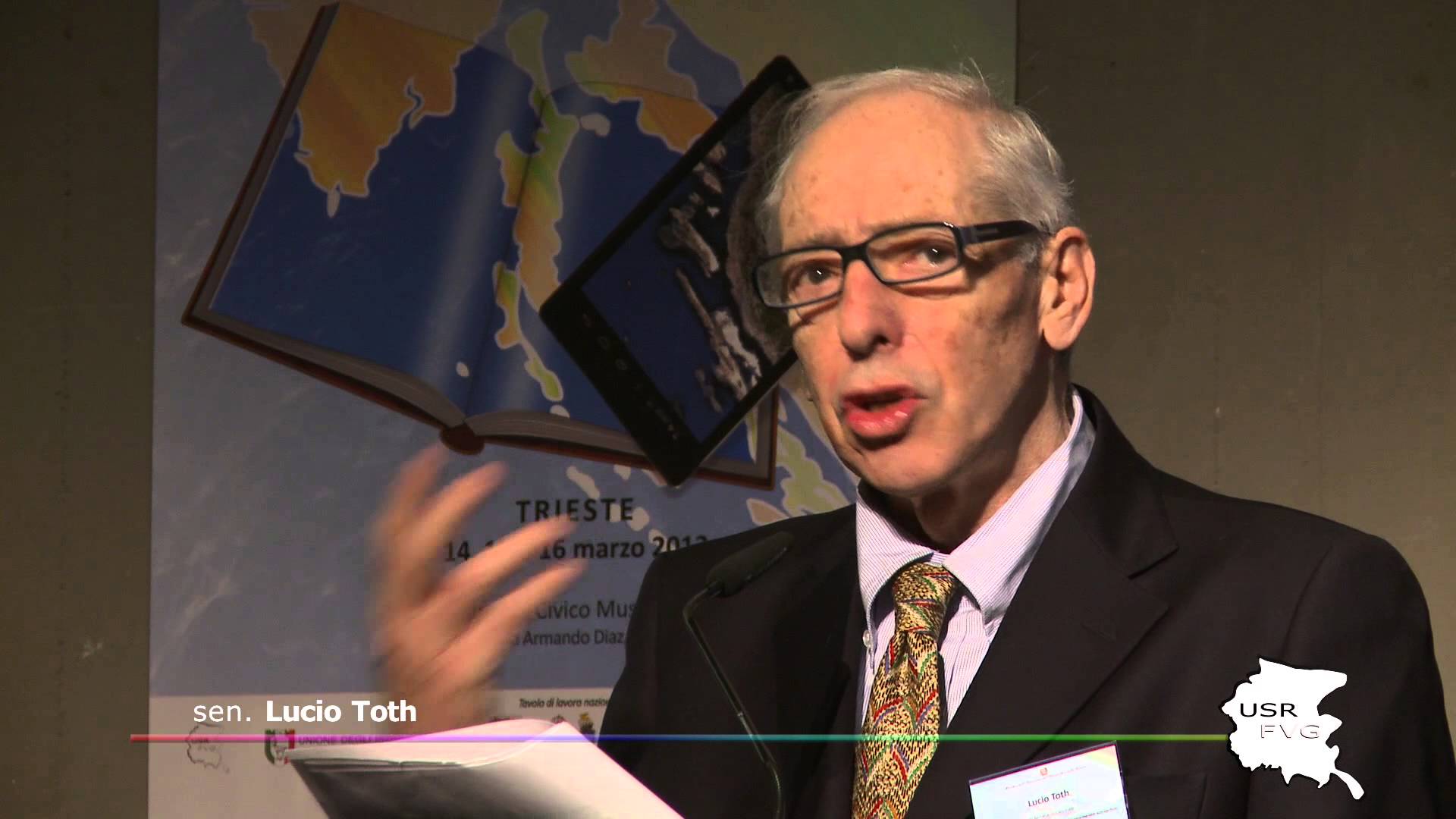Monza, quando Villa Reale era un campo per profughi
Tra il 1960 e il 1967 la reggia ospitò gli esuli fiumani. Cinquant’anni dopo due di loro sono tornati a visitare il luogo: «All’inizio sembrava un gioco».
La ripida scalinata di marmo in Villa Reale era lo scivolo dei pomeriggi d’inverno. Nelle belle giornate invece il cortile delle vecchie scuderie reali diventava, di volta in volta, campo di calcio, terreno di sfida per duelli con piccole spade di legno, punto di partenza per avventure nei giardini della reggia. C’è emozione nel racconto dei fratelli Adriano e Attilio Paulovich, esuli fiumani che, a cinquant’anni di distanza, sono tornati a Villa Reale, negli ambienti del campo profughi che sono stati la loro casa tra il 1960 e il 1967. «Siamo stati tra gli ultimi ad arrivare in Italia — racconta Adriano, classe 1948 — partiti il 14 settembre del 1958 siamo stati per sei mesi in una caserma a Udine, poi a Marina di Massa e dal 1960 a Monza dove il campo era stato realizzato nell’ala Sud della Villa Reale».
«Noi eravamo fortunati — spiega Attilio che nel 1960 aveva cinque anni, ma ricorda benissimo il lungo corridoio con l’infilata di porte —. Avevamo due stanze in fondo e godevamo di maggiore privacy, ma dai letti a castello ci si affacciava nelle case degli altri. I bagni erano in comune nell’atrio d’ingresso, ma avevamo un secchio vicino al letto per evitare di uscire di notte. Per farsi una doccia invece bisognava andare ai bagni pubblici di via Solferino, vicino al vecchio ospedale». Una vita dura, drammatica per gli adulti che a Fiume avevano lasciato casa, affetti e lavoro per poter essere italiani al cento per cento, una vita dalla libertà controllata perché «ogni spostamento doveva essere comunicato al direttore del campo che rilasciava i permessi».
Pagine di storia quasi dimenticate e ripercorse nel libro del monzese Umberto De Pace «L’esodo di istriani fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra» che sarà presentato il 28 aprile alla comunità italiana di Fiume insieme al volume «D’amore e d’orrore» dello stesso autore che ripercorre la vita di Aldo Juretich, giunto a Monza da rifugiato politico dopo aver subito le atrocità del campo di Goli Otok. Nelle parole di Adriano e Attilio i ricordi sono invece stemperati dall’inconsapevolezza dell’infanzia.
«I giardini reali in inverno erano chiusi al pubblico e mi sembrava di esserne il padrone — ricorda Attilio —, mi infilavo tra le sbarre della cancellata e avevo a disposizione giochi, ettari di verde, le acque del laghetto da attraversare in pedalò». La vita del cortile era una vita in comune con la sessantina di famiglie ospitate nel campo di Monza che è stato uno dei 109 realizzati dal governo italiano per dare accoglienza ai 300 mila in fuga dal regime jugoslavo: «In fondo, verso via Boccaccio — spiega Adriano — c’era la drogheria del Piero che era il punto di riferimento per tutti noi, mentre a metà del cortile una palizzata in legno ci separava da altre famiglie provenienti dal Sud d’Italia». Anche gli anni di scuola, prima di andare in collegio, sono stati all’interno del parco a cascina San Fedele: «Fuori dalla classe avevamo le mucche — spiega Attilio —, la coltivazione dei gelsi, all’intervallo si andava a caccia di rane nel Lambro. Una meraviglia».
A scuola la consapevolezza che la loro condizione non era proprio come quella dei compagni di classe: «Per me che ero il più piccolo la Villa è sempre stata la mia casa — spiega Attilio —, ma quando ho iniziato ad essere invitato dai miei compagni ho iniziato a vergognarmi di dove abitavo e non ho mai più invitato nessuno da noi». Il ‘67 l’addio alla Villa: «Siamo stati gli ultimi ad andarcene — ricordano i due — per noi il Comune aveva costruito cinque palazzine in via Luca della Robbia».
Corriere della Sera, 12 aprile 2017